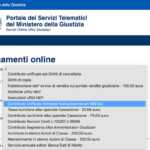ROMA – La costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è sempre più vicina. Il consiglio di amministrazione della Società Stretto di Messina ha approvato gli ultimi atti propedeutici al progetto definitivo, che sarà esaminato la prossima settimana dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Se il via libera arriverà nei tempi previsti, i cantieri potrebbero aprirsi entro la fine dell’estate.
A confermarlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha partecipato personalmente alla riunione. «Dopo anni di attese siamo finalmente a un passo dall’inizio dei lavori – ha dichiarato –. Il progetto, dal valore complessivo di 13,5 miliardi di euro, restituirà dignità a cinque milioni di siciliani e creerà migliaia di posti di lavoro tra Calabria e Sicilia».
Gli ultimi passaggi prima dell’apertura dei cantieri
Il Cipess, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, sarà chiamato a ratificare l’approvazione del progetto definitivo. Successivamente, la Corte dei Conti dovrà procedere alla validazione finale, passaggio necessario per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’avvio delle procedure di esproprio.
Il consiglio di amministrazione della società, guidata da Pietro Ciucci e presieduta da Giuseppe Recchi, ha intanto approvato gli atti aggiuntivi ai contratti con il contraente generale Eurolink (consorzio guidato da Webuild), con il project manager Parsons Transportation Group, con Edison Next Environment per il monitoraggio ambientale e con il broker assicurativo Marsh. È stato inoltre aggiornato l’accordo con il ministero delle Infrastrutture, con allegato il piano economico-finanziario che copre l’intero investimento tramite la legge di Bilancio 2025 e l’aumento di capitale della società deliberato nel 2023.
«Questa fase preparatoria è stata particolarmente complessa per la mole di documentazione e per il coinvolgimento di più soggetti istituzionali e privati – ha spiegato Ciucci –. Con l’approvazione del Cipess sarà possibile dichiarare la pubblica utilità dell’opera e avviare gli espropri, che saranno gestiti con gradualità e garantendo indennizzi superiori alla media».
Un progetto simbolo di sviluppo
Salvini ha definito il ponte un’infrastruttura “all’avanguardia”, attesa da decenni e destinata a rafforzare il ruolo dell’Italia come nodo strategico nel Mediterraneo. «L’Europa – ha aggiunto – attende quest’opera e ne riconosce l’importanza per la competitività del Paese».
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE

Con la sentenza n. 17195/2025, la Suprema Corte stabilisce che i canoni d’affitto già assegnati a un creditore non possono essere rivendicati da altri creditori…

Nel 2024 oltre un milione di italiani ha lasciato volontariamente il lavoro, nonostante in due casi su tre avesse un contratto stabile. La logistica tra…

Il riconoscimento del titolo straniero di avvocato diventa più difficile
Con una nota dello scorso 28 maggio, il Ministero della Giustizia ha chiesto al CNF regole più rigide per il riconoscimento del titolo straniero di…