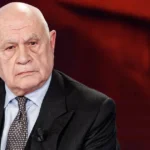Negli ultimi anni il sistema normativo in materia di prevenzione della corruzione si è dotato di strumenti e figure di garanzia sempre più articolati. A partire dalla legge n. 190 del 2012, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il controllo e la vigilanza sull’attività amministrativa, chiamato a elaborare e verificare l’attuazione di misure specifiche per contrastare il rischio corruttivo e garantire la legalità nell’azione pubblica.
La funzione del RPCT non si limita alla predisposizione formale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) o della sezione dedicata nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Essa investe anche il controllo concreto del funzionamento amministrativo, attraverso il monitoraggio costante dei tempi procedimentali e la segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni che, anche in assenza di episodi conclamati di corruzione, possono rappresentare segnali preoccupanti di cattiva gestione.
Il caso e il chiarimento dell’ANAC
Un recente parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, datato 9 aprile 2025, ha offerto l’occasione per ribadire il perimetro delle responsabilità in capo ai RPCT. Il caso riguardava una Regione del Sud Italia, dove una segnalazione sindacale aveva evidenziato l’inerzia di un ufficio regionale nel concludere l’accordo integrativo per la specialistica ambulatoriale interna. Il RPCT locale aveva escluso ogni propria competenza in materia, archiviando la segnalazione.
L’ANAC ha però chiarito che, pur non avendo poteri sostitutivi o gestionali diretti, il RPCT è tenuto a vigilare sull’attuazione di tutte le misure organizzative previste nei Piani anticorruzione e, tra queste, rientra a pieno titolo il monitoraggio dei tempi procedimentali. La legge 190/2012 prevede infatti, all’art. 1, comma 9, lettera d), e al comma 28, che il rispetto dei termini amministrativi sia misura obbligatoria di prevenzione della corruzione.
Anche in assenza di dolo o danno materiale, il protrarsi dei procedimenti oltre i termini stabiliti può configurare una disfunzione organizzativa rilevante ai fini del controllo anticorruzione, imponendo al RPCT di avviare verifiche, raccogliere elementi informativi, coinvolgere l’ufficio interessato e segnalare le criticità agli organi politici e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Un controllo sostanziale, non solo formale
Il valore di questo chiarimento risiede nella riaffermazione di una concezione sostanziale e dinamica della funzione anticorruzione. Il RPCT non è un mero compilatore di piani e relazioni, ma un presidio attivo di legalità e buon andamento dell’amministrazione. Deve rilevare segnali di inefficienza, indagare sulle cause di eventuali inerzie e proporre soluzioni organizzative, in modo da prevenire situazioni che, se trascurate, potrebbero degenerare in illeciti veri e propri.
In questa prospettiva, il rispetto dei tempi amministrativi diventa indicatore dello stato di salute dell’apparato pubblico. Il principio di trasparenza, d’altronde, impone che l’attività della pubblica amministrazione sia non solo regolare, ma anche tempestiva, garantendo ai cittadini risposte certe in tempi ragionevoli.
Trasparenza e responsabilità diffusa
Il sistema di prevenzione delineato dalla legge prevede inoltre che i risultati dell’attività del RPCT siano oggetto di rendicontazione annuale, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della relazione sull’attuazione delle misure anticorruzione. Questo consente non solo un controllo interno, da parte degli organi di governo e controllo, ma anche un controllo esterno, da parte dei cittadini e dei portatori di interesse, in linea con i principi dell’open government.
Il parere dell’ANAC assume così un valore sistemico: chiarisce che i poteri e i compiti del RPCT non devono essere letti in senso restrittivo, ma interpretati come strumenti funzionali a garantire un’amministrazione trasparente, efficiente e impermeabile ai fenomeni corruttivi. Le inerzie amministrative, lungi dall’essere semplici contrattempi, possono costituire indizi di criticità più profonde. Ed è compito del RPCT intercettarle, valutarle e sottoporle all’attenzione degli organi competenti, promuovendo un modello di pubblica amministrazione più responsabile e orientata alla qualità del servizio.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE

Nuove scadenze degli obblighi contributivi per gli avvocati
Sul sito CFnews è stata pubblicata la notizia relativa ai nuovi termini per adempiere agli obblighi contributivi di Cassa Forense attualmente sospesi fino al 30…

L'Ordine degli Avvocati di Roma condivide appieno la decisione del Presidente ff. del Tribunale di Roma di sospendere l'app con la quale si depositano gli…

Con la sentenza n. 16242, la Suprema Corte ribadisce che, nelle adozioni in casi particolari, il superiore interesse del minore prevale sul diniego della madre…